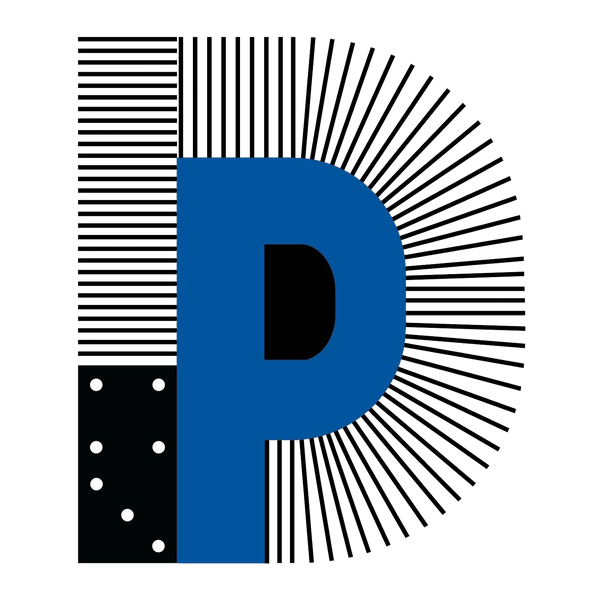AUTORITRARSI
O guardarsi per quello che si è
In uno spazio scenico nudo, sventrato, trasparente nel suo rivelarsi senza abbellimenti, Davide Enia con Autoritratto travolge lo spettatore in una confessione intima e personale che è anche un’orazione civile, un canto epico che riesce nell’impresa di descrivere un’intera generazione. Attraverso un racconto plurale in cui parole, memorie e voci diverse si fondono in un unico corpo, l’esperienza personale si intreccia con alcuni dei fatti storici che più hanno definito la storia del nostro paese, dagli anni di piombo a Palermo ai maxi processi antimafia, fino alle stragi di Capaci e Via d’Amelio. Nonostante l’intelaiatura dello spettacolo sia in realtà la biografia stessa dell’artista, nessuno tra il pubblico riesce a sottrarsi a ciò che accade sul palco: la continua personalizzazione degli eventi rende la narrazione carnale e mai retorica, tanto che quando, all’ultimo, viene chiamato il buio, ci si ritrova sospesi, commossi, ancora in tensione. E ci si chiede dove sia accaduto veramente lo spettacolo, se sul palco o nell’immaginario di chi guarda.
“Se ti trovi di fronte a una pozza di sangue, l’immagine riflessa è il tuo autoritratto”: si conclude così Autoritratto, ultimo lavoro di Davide Enia, in scena al Teatro India di Roma dal 20 maggio al 1 giugno. Debuttato al Festival dei Due Mondi di Spoleto 2024, lo spettacolo è il risultato non solo di una puntuale e approfondita documentazione storica, ma soprattutto di un personale percorso di autoanalisi. Ed è proprio durante il talk che Enia confessa come solo dopo molti anni sia riuscito finalmente a porsi le domande giuste, chiedendosi quindi non tanto cosa sia la mafia in assoluto, ma quanto della mentalità mafiosa sia rimasto dentro di sé. Ripercorrendo alcuni degli eventi più cruenti degli anni ‘90, Enia intreccia e porta a galla le proprie memorie: sono i ricordi di un bambino che ha visto il primo morto ammazzato a soli otto anni e che dopo la maturità è voluto scappare da una città abbandonata a sé stessa, ma che già allora aveva compreso l’importanza di nominare le cose, imparando a osservare il male senza mitizzarlo, riconoscendolo per quello che è.
A questo si aggiungono le storie segnate da un comune senso di frustrazione e indignazione di tanti amici e amiche che, come lui, sono cresciuti in una realtà che aveva normalizzato la presenza latente delle dinamiche di mafia, che aveva normalizzato la paura e la convivenza con la morte. Se la quotidianità dei palermitani era la storia nel suo farsi, ben si comprende come in questo progetto artistico le tante singole microstorie individuali regalino nuove e diverse prospettive all’evento macrostorico. Dare un volto umano alla freddezza e alla tragicità dei fatti permette a chi guarda di stringere un patto di confidenza con l’artista, lasciandosi guidare con maestria all’ascolto di ciò che, per senso di pudore e umanità, risulterebbe inascoltabile.

Accompagnato dalla chitarra di Giulio Barocchieri, Enìa recupera una tradizione narrativa e musicale tipicamente siciliana, quella del cunto, antica tecnica vocale caratterizzata dallo spezzare continuo delle parole e dei fiati che restituisce al pubblico un racconto frastagliato e concitato. La variazione ritmica del respiro spinge ad un’attenzione sempre maggiore, portando quasi ad un cambiamento nel modo di incamerare ossigeno, coinvolgendo chi ascolta in un ritmo intenso e incalzante, che finisce col dare vera e propria sostanza sonora alle parole. Dal Miserere di Sessa Aurunca alle colorite abbanniate palermitane, dello spettacolo è propria una costruzione quasi sinfonica, che dà nuova vita ad una lingua antica e carnosa, figlia di una terra lontana, che affonda le proprie radici nel mito e nella ritualità, nel sacro delle messe e nel profano dei mercati.
Autoritratto è un’opera che nasce per provare a dare risposta ad una crisi del presente, e lo fa partendo da una prospettiva personale che subito si allarga, sconfina e finisce per accogliere e travolgere tutti. Fin dalla costruzione dello spettacolo è chiaro come il rapporto tra scrittura e scena si pieghi alla necessità di confrontarsi con una comunità che osserva: come nella narrazione epica classica, la visione di ciò che accade sul palco è sempre collettiva, condivisa, mai delegata al singolo. Enia crea un linguaggio comune tramite una narrazione vibrante e in continua tensione, in cui il corpo si rilassa e si contrae, in cui parola e verbo si fanno carne: così, spazializzando l’immaginario, permette a chi osserva di ritrovarsi tra le strade di Palermo, di vedere le foglie sull’asfalto e i lenzuoli bianchi sventolanti alle finestre. Palermo, la città che si conosce veramente solo dopo aver lasciato.
Perché per conoscersi veramente è necessario allontanarsi, specchiarsi nel riflesso degli occhi di chi guarda.
Abituarsi all’altro, a ciò che non si conosce o comprende. Al discontinuo.
Perchè per farsi un autoritratto è necessario prendere le distanze da se stessi, o il rischio è di non conoscersi mai.
Anna Cipriani e Vittoria Ferraro Petrillo